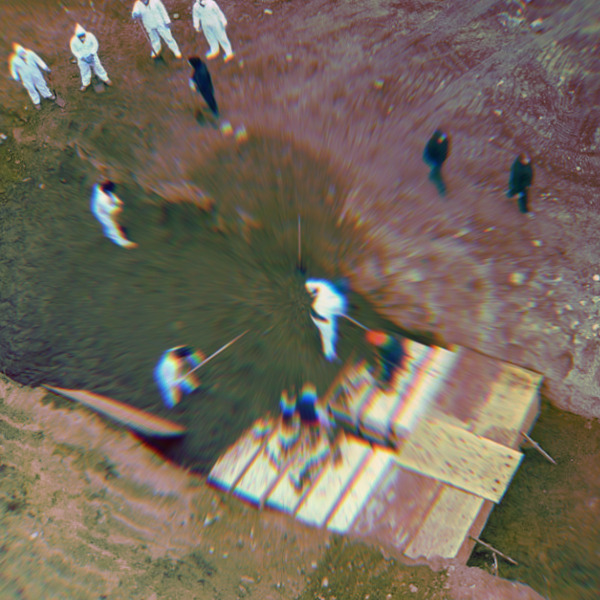 di G. Mazzetti
di G. Mazzetti
In molti lamentano oggi una debolezza dei lavoratori, anche se ben pochi si arrovellano sulle condizioni per rovesciare gli attuali rapporti di forza tra le classi. Ma per non tornare a ripetere gli errori passati è indispensabile non riferirsi alle vicende storiche in forma mitica. Provo a ricostruire le vicende che ci hanno condotto alla situazione attuale per come le ho vissute.
-
Se si pone la questione sul terreno della maggiore o minore forza del lavoro salariato, e di come recuperarla, secondo me si elude il vero problema. Bisogna piuttosto interrogarsi sul perché e quando il lavoro, o meglio i lavoratori, sono diventati deboli.
-
Non siamo più infatti in pieno Ottocento, quando i sindacati e i partiti di sinistra erano osteggiati e perseguitati e il mondo era qualcosa sul quale i lavoratori, che in genere non potevano nemmeno votare, non potevano mettere bocca. Come viene giustamente richiamato da alcuni, a metà Novecento “la classe operaia aveva conquistato alti livelli di soggettivazione politica, aveva cambiato [a suo favore] i rapporti di forza tra le classi e l’insieme dei rapporti sociali … esercitando un’influenza egemonica su tutte le manifestazioni politiche e culturali del paese”, inclusa la distribuzione del reddito. Contrastava, inoltre, tutte le condizioni lavorative che venivano sperimentate come non tollerabili. Posso confermarlo perché c’ero, e facevo la mia parte.
-
Quale fenomeno ha fatto dissolvere quell’egemonia? Che cosa ha determinato “la progressiva erosione e la cancellazione di tali conquiste”? La cosa non è successa dalla mattina alla sera, bensì nell’arco di un decennio, a partire dalla metà degli anni settanta. In quel periodo, le vecchie parole d’ordine, incentrate sul rispetto dei diritti sociali, hanno cominciato a perdere sempre di più la loro consistenza, svuotando progressivamente le lotte della loro efficacia. I conflitti, infatti, o trovano il bandolo della matassa che consente la tessitura di un progetto in grado di confrontarsi con i problemi emersi, o finisce col trasformarsi in un trito rituale consolatorio, di mera autoconferma. Anche qui, posso purtroppo dire che c’ero, ed ho assistito alla trasformazione dei roboanti proclami di inizio anni sessanta, in trite giaculatorie pronunciate per consolarsi, che vengono ripetute da decenni.
-
Cercare di spiegare tutto ciò con il fatto che il capitale è tornato ad imporsi, è solo una banale tautologia. Nel contrasto è infatti del tutto ovvio che vince il più forte. Ma chi vuole veramente battersi, non deve ricorrere a simili lamenti autogiustificativi. Deve piuttosto comprendere che cosa, nella lotta, permette all’avversario di prevalere. Un rovesciamento che dimostra che la precedente egemonia era illusoria, in quanto poggiava su una base culturale che non era in grado di reggere lo stesso processo evolutivo, che quella prevalenza aveva innescato.
-
La debolezza di un soggetto non è mai un evento arbitrario, e se si vuole agire razionalmente occorre spiegarselo.
-
In che cosa consisteva la conquista dell’egemonia che aveva preso corpo con lo stato sociale keynesiano? A mio avviso nella capacità nuova di riprodurre il lavoro al di là dei limiti dei rapporti capitalistici, che rafforzava gli individui nella loro lotta di classe. Nei paesi OCSE la disoccupazione, grazie al crescente intervento dello stato nell’economia, fu infatti per ben un trentennio (1945-1975) inferiore al 3%. Un intervento e un esito che nella fase storica precedente erano stati preclusi. E a che cosa corrispondeva la successiva perdita di quell’egemonia? Al presentarsi di una crescente difficoltà di riprodurre il lavoro salariato, anche da parte dello stato, determinata dal mutare delle circostanze. A partire da metà anni settanta le politiche che prima avevano garantito il pieno impiego cominciarono, infatti, in tutti i paesi, a dimostrarsi inefficaci, indebolendo la posizione dei lavoratori
-
Che cosa hanno fatto le forze (partiti, sindacati, movimenti) che avevano prima espresso quell’egemonia? Hanno rifiutato questo fatto, aggrappandosi alla convinzione che l’unico modo di procedere sulla via dello sviluppo fosse quello di riprodurre il lavoro come si era imparato a fare con lo stato sociale keynesiano. E se il lavoro veniva a mancare era solo perché gli imprenditori ne ostacolavano la riproduzione. Le vicende delle lotte dei minatori inglesi sono, da questo punto di vista, emblematiche.
-
Ma chi cerca in ogni modo di riversare sul mercato una merce che non ha uno sbocco, anche se questa è la forza lavoro, finisce inevitabilmente col subire il potere del contraente, che non solo deciderà il prezzo, ma anche la condizione del suo uso. Né basta che il lavoratore urli “lavoro!”, “lavoro!”, perché le sue grida non esprimono più un potere, bensì la sua impotenza.
-
Qui è dov’è sopravvenuto un apparente paradosso, che non sono riuscito a far accettare a nessuno dei miei numerosi interlocutori nel corso degli ultimi quarant’anni. La difficoltà di riprodurre il lavoro non è un segno di impoverimento della società. Al contrario essa si verifica perché la società si è straordinariamente arricchita.
-
Il riconoscimento di questo fatto costituiva già una conquista di Keynes. Questi proponeva delle politiche del pieno impiego sostenute dalla spesa pubblica, perché era convinto che i problemi esplosi nella Grande Crisi non fossero dovuti alla mancanza di risorse, ma all’incapacità di impiegarle in obiettivi diversi dall’accumulazione di capitale. Per questo occorreva soddisfare i grandi bisogni sociali negando qualsiasi priorità al movente accumulativo. Anche se ciò avrebbe dato un po’ di respiro alla stessa accumulazione, offrendo alle imprese occasioni di sbocco.
-
Perfino un conservatore come Keynes riconosceva però che la possibilità di riprodurre il lavoro, grazie all’intervento dello stato, sarebbe stata, come riconosceva Marx, una strategia valida solo per una breve fase storica, cioè fintanto che dominava la penuria. (Lui prevedeva che sarebbero bastate un paio di generazioni.)
-
Pertanto, i lavoratori oggi sono deboli perché si battono per ottenere la riprodurre del lavoro come forma di partecipazione alla riproduzione individuale e collettiva, confidando che basti la lotta di classe per tornare prima o poi alla vecchia gloria. Il loro destino, non dissimile da quello che le patate subiscono sul mercato, deriva dal fatto che si comportano come patate, rivendicando la comparsa di acquirenti della loro capacità produttiva, nonostante non sussistano più le condizioni di uno sviluppo su questa base. Vogliono essere riconosciuti come individui, con i loro bisogni e con le loro capacità, pur continuando a porsi come merci.
-
Ma le conquiste realizzate con lo stato sociale keynesiano si spingevano già molto al di là del puro e semplice contrasto di classe, perché incidevano contemporaneamente sui bisogni – non più concepiti solo in forma privata – che sull’attività che li soddisfaceva – finalizzata in buona parte a garantire quelli che abbiamo chiamato diritti sociali.
-
Da quel passaggio storico positivo non è però scaturito l’individuo consapevolmente sociale di cui parlava Marx, in quanto si è fantasticato di aver in quel modo conquistato l’assetto ultimo dell’organizzazione sociale.
-
Poiché le lotte attuali non si scostano dalla modalità che ha prevalso negli ultimi quarant’anni, è impossibile sperare in un rovesciamento della situazione: i lavoratori continueranno a dover soffrire della loro evidente debolezza.
-
Il compito, per chi volesse eventualmente provare ad uscire dalla crisi in cui stiamo impantanati, è quello di riconoscere che né le imprese, né lo stato possono garantire una riproduzione del lavoro in misura tale da assicurare una nuova fase di sviluppo.
-
Bisogna però essere consapevoli che non si tratta di un passaggio culturale semplice. Se dall’emergere della crisi, sul finire degli anni settanta, i lavoratori hanno cominciato a perdere progressivamente la forza che avevano acquisito dal dopoguerra, è stato proprio perché erano incapaci di elaborare spontaneamente i cambiamenti necessari, spingendosi al di là delle forme sociali attraverso le quali abbiamo costruito la civiltà occidentale negli ultimi duecento anni.
-
Per questo non basta ridurre la strategia al semplice perseguimento dell’obiettivo politico della riduzione della giornata lavorativa e della redistribuzione del lavoro necessario tra tutti, obiettivo per cui mi batto da più di quarant’anni.
-
Occorre piuttosto riconoscere che tutte le forme dell’individualità, attraverso le quali abbiamo dato vita al nostro mondo, sono inadeguate al compito di farlo evolvere ulteriormente secondo i nostri bisogni e le nostre aspettative.
-
Siamo cioè piombati in una situazione contraddittoria, nella quale o “interviene una trasformazione rivoluzionaria dell’intera società o sopravverrà la comune rovina con la classe contro la quale stiamo lottando”.
(Per eventuali approfondimenti www:redistribuireillavoro.it Quaderni di formazione on line n. 3/4/5/6/7/8 2016 “E se il lavoro fosse senza futuro?)”
Giovanni Mazzetti, Presidente, Associazione per la redistribuzione del lavoro. Già docente di Economia Marxista ed Economia del lavoro. Ha pubblicato numerosi testi sulla crisi con Dedalo, Datanews, Bollati Borighieri, Editori Riuniti, Asterios, Manifestolibri, Schirru, Punto Rosso, Rubbettino.
