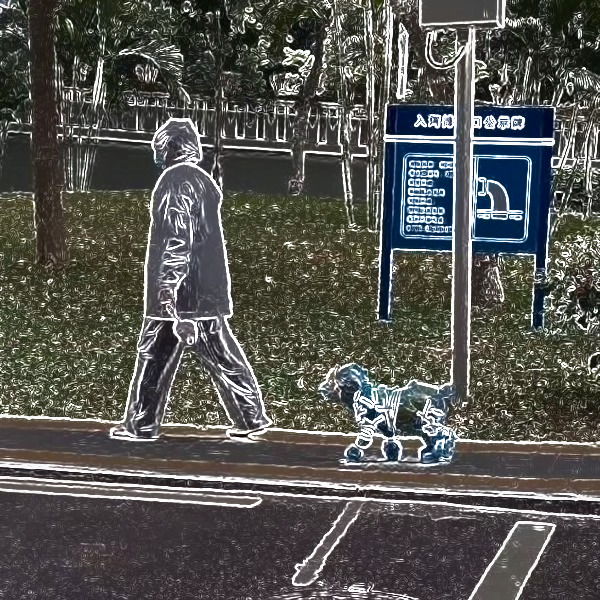
di: R. Laghi
Un approccio linguistico-etimologico
Competenze, scrive Boarelli in Contro l’ideologia del merito, è “una delle parole chiave del lessico costruito intorno al merito” (Boarelli 2019, pp. 218-219). Da dove nasce questo concetto? Lo stesso Boarelli ne ricostruisce l’origine e la diffusione, a partire dal libro bianco dell’Unione Europea Crescita, competitività, occupazione, presentato nel 1993 e tappa chiave di un percorso di adesione dell’UE a una visione neoliberale della società (il principio fondante del testo è la “valorizzazione del capitale umano”). Ma che cosa è la competenza?
Se il vocabolario Treccani insiste in primo luogo sugli aspetti legati al diritto processuale e amministrativo (come “misura della giurisdizione attribuita a ciascun ufficio giudiziario” e “complesso delle attribuzioni degli organi dello stato e delle persone giuridiche pubbliche in genere”), per estenderne il significato alla “capacità, per cultura o esperienza, di parlare, discutere, esprimere giudizi su determinati argomenti”(1), chi saprebbe definire con precisione il termine “competenze” impiegato in sempre più contesti (con predilezione per l’educazione e il mondo del lavoro)? Difficile definirlo, perché la vaghezza è stata una sua caratteristica fin dai primi impieghi. E non è un caso. Perché “le competenze giocano un ruolo determinante in questo processo di subordinazione alla visione del mondo economico, perché spingono i sistemi educativi ad abbandonare la costruzione di saperi critici in favore dell’organizzazione di saperi strumentali” (Boarelli 2019, p. 274). Strumentali a cosa? A portare sull’individuo ogni responsabilità, a confinarlo in quella visione del mondo che, da Margaret Thatcher (“La società non esiste. Esistono gli individui, gli uomini e le donne, e le famiglie.”) arriva fino al self-branding e alla retorica del successo contemporaneo (2).
Ancora Boarelli: “le competenze agiscono quindi come dispositivi di disaggregazione, contribuiscono a indebolire i legami sociali e le forme di cooperazione, favoriscono la costruzione di identità individuali competitive sul piano economico e autosufficienti sul piano sociale. L’efficacia di questi dispositivi deriva innanzitutto dalla loro capacità di trasformare in modo progressivo e silenzioso il sistema educativo. Poiché una persona competente agisce da sola nel mondo in modo concorrenziale, il sistema nel quale formerà le proprie competenze deve essere basato su una cultura individualistica e competitiva” (Boarelli 2019, p. 306).
Ci pensa Leopardi, citato in coda alla definizione nel vocabolario Treccani, a riportarci al significato etimologico, alla radice di questo concetto: competizione. L’etimologia delle due parole è infatti la stessa e ha la funzione di svelarcene il senso, nel contesto delle società neoliberali in cui viviamo: le competenze sono necessarie alla competizione, all’“imperativo diffuso dell’auto-imprenditorialità” (D’Alia). E qual è l’orizzonte dell’auto-imprenditorialità? Il mercato. Conviene rimanere ancora un istante nel campo dell’analisi etimologica: alla radice di mercato c’è merce, dal latino “mercari” che a sua volta sarebbe una derivazione di “merere”, nel senso di “meritare, acquistare, guadagnare”, con il significato originario (di derivazione greca) di toccare in parte, partecipare. Ma “merere” è anche all’origine di merito. Non stupisce, quindi, che l’elogio costante della meritocrazia sia al suo apice nel periodo storico in cui il mercato viene imposto come modello e misura di ogni aspetto del vivere collettivo e individuale, a discapito di una visione della società basata su diritti e vera uguaglianza. “Ciò che bisogna pretendere non è meritocrazia, ma giustizia!”, diceva lo scrittore Stefano Tassinari agli “indignados” accampati in Piazza Maggiore a Bologna nel 2011 (3).
Perché iniziare dalle parole e dalla loro etimologia? Perché la questione, oltre che politico-economica e sociale, è anche – e ai suoi fondamenti – un problema di linguaggio, inteso come capacità di descrivere e rappresentare la realtà. Fitoussi parla di “regole di governo e regole di vocabolario che tracciano una strada da cui pare impossibile deviare”(Fitoussi 2019, p. 3). Il mito del merito (e della meritocrazia), di queste regole di governo e di vocabolario è diventato un elemento portante, usato sistematicamente per isolare l’individuo dalla società in cui si trova ad agire.
La retorica del merito per nascondere le disuguaglianze
Se guardiamo all’Italia, niente esemplifica meglio la posizione dell’ideologia neoliberale nei riguardi dei concetti di merito e meritocrazia come l’intervento della ministra Teresa Bellanova alla Leopolda (10):
“Chi ce l’ha fatta non è un nemico, chi ce l’ha fatta deve essere riconosciuto come buona pratica per essere d’esempio anche agli altri perché ce la possiamo fare, perché noi dobbiamo dare fiducia in questo paese, perché chi ce l’ha fatta ce l’ha fatta per merito e il merito è di sinistra. A quelli che pensano che tutti possano avere tutto, noi vogliamo dire che il merito è di sinistra e il merito, che si tratti della selezione delle classi dirigenti, che si tratti di concorsi, che si tratti di dirigenti da individuare nella pubblica amministrazione, il merito è il nostro unico parametro di misura.” (4)
Fitoussi individua proprio in questa argomentazione uno degli elementi della “neolingua dell’economia”: “le disuguaglianze si ostentano, non sono mai state tanto esibite: alcuni conducono vite da cani, altri da nababbi. La risposta in neolingua è risaputa: «Il problema è che non amate i ricchi, che non sopportate chi ha avuto successo».” (Fitoussi, 2019, p. 173)
Si tratta della stessa retorica che contraddistingue – tra gli altri – gli interventi del presidente francese Macron, cristallizzata in maniera limpida in un passaggio del suo discorso per l’inaugurazione della Station F, un campus dedicato alle start-up (e non a caso interamente finanziato da Xavier Niel, fondatore e maggiore azionista del gruppo Iliad e co-proprietario del gruppo Le Monde) a giugno 2017: «Une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien». (5)
“Les gens qui réussisent“ di Macron sono gli stessi che ce l’hanno fatta di cui parla Bellanova. Un discorso politico che sceglie il merito (e di conseguenza la riuscita, il successo) come parametro unico, che postula che ciò dipenda esclusivamente dall’impegno individuale, occulta le disuguaglianze che attraversano la società e rendono le condizioni di partenza drammaticamente diverse, a un tal punto che un percorso di successo è, per alcuni, escluso a priori. Si potrebbe inoltre affermare che, adottando questa visione, la politica (italiana) rifiuta la responsabilità di attuare l’articolo 3 della Costituzione Italiana: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” (6)
I cambiamenti che avvengono sul piano linguistico procedono in parallelo a quelli economico-politici, in una sorta di loop in cui si sostengono e rinforzano a vicenda e che porta a percepire questo sistema linguistico-economico come naturale, come l’unico possibile. Le conseguenze sugli individui e sulla società sono quotidianamente visibili. Ci troviamo a usare un linguaggio sempre più scarno che limita la nostra capacità di articolare un pensiero critico all’ideologia neoliberale, responsabile di aver svuotato parole ed espressioni del loro significato originario (basti pensare a “riforma”) portando avanti una deformazione del linguaggio con obiettivi precisi. Il passaggio da “cittadini” a “utenti” (“consumatori”) è un altro esempio dell’operazione ideologica in atto da tempo sul linguaggio. Non solo: come fa notare David Graeber, se l’1% della popolazione controlla la fetta più grossa di ricchezza disponibile, è il loro linguaggio a designare cosa loro considerano importante (Graeber 2019, p. XVIII). La società, le istituzioni, la famiglia e l’individuo devono essere concepiti in termini di impresa. A chi non si adegua resta solo il fallimento (e lo stigma sociale), come vedremo più avanti.
“Se la conoscenza che i cittadini hanno di ciò che sta loro intorno, dei luoghi in cui lavorano o studiano e delle istituzioni che li rappresentano è filtrata attraverso un vocabolario di matrice economica, è inevitabile che il loro punto di vista ne sia condizionato. (…) Il risultato di questa combinazione tra il dominio del vocabolario economico e quello del vocabolario specialistico è la trasformazione della funzione stessa del linguaggio, che assume un ruolo esclusivamente operativo, strumentale, a discapito della sua dimensione analitica e critica.” (Boarelli 2019, p. 848)
Un quadro simile emerge dall’analisi che Daniel Markovits traccia nel suo The meritocracy trap. How America’s foundational myth feeds inequality, dismantle the middle class and devours the elite. Il lavoro di Markovits riflette la società statunitense in cui nasce e inquadra le conseguenze distorsive della meritocrazia, individuandola come causa dell’aumento della disuguaglianza e della polarizzazione della società americana: da un lato una élite che ha sempre più i connotati di casta aristocratica, dall’altro una classe media sempre più esclusa dalle opportunità di mobilità sociale. Polarizzazione che continua ad alimentare, in un circolo sempre più vizioso (e violento), rancore, odio e paura tra le classi nella società americana. Considerato che la meritocrazia è uno dei miti fondativi degli Stati Uniti, il quadro tracciato da Markovits non è del tutto sovrapponibile al contesto europeo e italiano in particolare, ma delinea alcune tendenze in atto anche nelle nostre società. L’aumento del divario tra “chi ce l’ha fatta” e “chi non è niente” è causa di instabilità politica e forti tensioni sociali. “Whereas aristocratic inequality was both wasteful and unjust, meritocratic inequality declares itself at once efficient and just” (Markovits 2019, p. 508): è proprio da questo artificio retorico (falso) che prende corpo il sentimento di rancore e risentimento che attraversa la società. Politica e linguaggio hanno scaricato ogni responsabilità sull’individuo (inteso come capitale umano da valorizzare, da portare al successo), così che il disagio dell’individuo spinto sempre più ai margini non può essere espresso in termini di ingiustizia – considerando anche che la retorica della meritocrazia è spesso adottata dalle sue stesse vittime, perché appare intrinsecamente giusta: il disagio dell’individuo contemporaneo prende dunque la forma del populismo e del nativismo, linguaggi di coloro che non hanno più linguaggio per esprimere l’ingiustizia, “victims without a language of victimhood” (Hochschild, citato in Markovits 2019, p. 1335).
“La stimolazione di un nuovo tipo di soggettività basato sulla competizione muta la natura dei legami sociali, indeboliti da una visione marcatamente individualista: ciascuno deve affermare se stesso, meritare il proprio successo, autodisciplinarsi per non essere incluso nella categoria dei non meritevoli.” (Boarelli 2019, p. 799)
E ai non meritevoli cosa succede?
Il rifiuto del fallimento e la sua privatizzazione
“We sprint as much to outrun failure as to catch success. Failure conjures such vivid pictures of lost souls that it is hard to imagine a time, before the Civil War, when the word commonly meant “breaking in business”—going broke. How did it become a name for a deficient self, an identity in the red? Why do we manage identity the way we run a business—by investment, risk, profit, and loss? Why do we calculate failure in lost dreams as much as in lost dollars?” (Sandage 2006, p. 2)
Sandage sottolinea come il termine fallimento (“failure”) sia passato dalla sfera economica e aziendale (dove identifica la bancarotta) al discorso sull’io, sull’esistenza umana, sul non riuscire: ancora un esempio dello slittamento semantico verso il linguaggio dell’economia, dell’impresa.
In questa visione del mondo e della vita umana, il fallimento è relegato a disfunzionalità individuale e le cause strutturali e sistemiche sono rimosse dal quadro di analisi. Disfunzionalità individuale che porta a stress, ansie, depressione. Un disagio che viene medicalizzato e relegato alla sfera privata, a colpa individuale attraverso l’uso della retorica del merito, dell’elogio di “chi ce l’ha fatta” e dell’additare, con disprezzo, chi invece non è riuscito ad arrivare al successo (come se fosse equamente accessibile a tutti).
“The privatisation of stress is a perfect capture system, elegant in its brutal efficiency. Capital makes the worker ill, and then multinational pharmaceutical companies sell them drugs to make them better. The social and political causation of distress is neatly sidestepped at the same time as discontent is individualised and interiorised.” (Fisher 2018, p. 467)
Il ritornello è sempre lo stesso. Le radici di questa visione del mondo affondano già nella società americana del diciannovesimo secolo, come ci ricorda Sandage, e nelle parole usate per descrivere “chi non ce la fa” riecheggiano le parole usate per descrivere gli schiavi. La giustificazione morale dei sistemi basati sulla disuguaglianza ha radici profonde.
“The great American Assumption” promoted the idea that men who were failures simply lacked ability, ambition, or both; what had once been said of the captives of slavery now belittled the misfits of capitalism. The new birth of freedom was an ideology of achieved identity; citizen and slave gave way to success and failure as the two faces of American freedom. That ideal depended not only on the chance of success but on the risk of failure. (…) The problem is not that our bootstrap creed is a bald-faced lie, although it is. The real problem is that failure hits home; we take it personally. To know a “great loser”—a father, a neighbor, a classmate—is to glimpse our own worst future. Times change, deals collapse, accidents happen. (Sandage 2006, p. 18)
Non stupisce, quindi, che il fallimento, relegato a questione privata, a una supposta mancanza di determinazione, coraggio, talento sia vissuto come colpa personale; si opera così un rovesciamento di prospettiva che, nella mente della persona che “fallisce”, suona come “il sistema va bene, sono io che non sono capace.” La critica è rivolta in esclusiva contro il sé fallimentare e mai contro un sistema ormai percepito come unico possibile. L’artificio è linguistico, le conseguenze sono reali e drammatiche. La percezione delle ingiustizie e lo scontento non riescono così a trasformarsi in un’espressione collettiva di rabbia, rimanendo focalizzate verso l’interno. Trasformare questa depressione in rabbia politica è un progetto politico necessario, scriveva Mark Fisher (Fisher 2018, p. 645). Ma questo è possibile nella società del merito?
“L’ideologia del merito è ostile al conflitto. Il conflitto sociale si nutre dell’azione collettiva, il merito dell’iniziativa individuale. Il primo persegue scopi comuni che investono la società nel suo complesso, il secondo concepisce il progresso sociale come ricaduta naturale di una somma di successi personali. L’uno prefigura un diverso ordine sociale, l’altro conferma quello esistente.” (Boarelli 2018, p. 1132)
“(…) uno dei motivi dell’assenza di conflitto sociale è proprio il dilagare della depressione. “(Arminio 2020, p. 89)
Al conflitto, sostiene Boarelli, si è sostituito lo scontro: contrapposizioni aprioristiche che propongono una visione semplificata della realtà, senza nessuna componente costruttiva. Lo vediamo all’opera quotidianamente nel dibattito pubblico, nella polarizzazione (urlata) di fazioni che si contrappongono senza confrontarsi, spesso sul tono dell’insulto o del disprezzo. Ma anche nell’individuazione pretestuosa di gruppi o categorie additati come capro espiatorio contro cui scagliare, di volta in volta, il rancore dei cittadini. E proprio i non meritevoli sono tra i bersagli più ricorrenti, proprio perché, secondo le logiche analizzate fino a qui, sono considerati i soli colpevoli della propria situazione. Di rimando, sia detto en passant, chi ha successo lo imputa unicamente al proprio merito, automaticamente elevandosi a una posizione di auto-proclamata superiorità morale. Ma pretendere che il successo di alcuni non sia collegato al fallimento di altri è una pura illusione. (7)
Coltivare ombre, fallire meglio
Se il sistema di valori è unico, tutti coloro che non si conformano (sia che non vogliano sia che non riescano) vengono relegati ai margini, esclusi, disprezzati. L’accelerazione impressa da nuovi media e dispositivi mobili ha reso questo processo ancora più pervasivo: basta pensare all’uniformazione che passa attraverso i media mainstream e i social network commerciali, che hanno declinato in ancora nuove forme la retorica del successo e l’auto-sfruttamento necessario a raggiungerlo. L’imposizione di una lingua unica e di una visione unica della società corre ancora più forte, in un circolo che si autoalimenta.
“This instant is insomniac, amnesiac: it locks us into a reactive time, which is always full (of outrage and pseudo-novelty). There is no continuous time in which shadows can grow, only a time that is simultaneously seamless (without gaps: there is always ‘new’ content streaming in) and discontinuous (each new compulsion makes us forget what preceded it). The result is a mechanical and unaknowledged repetition. Is it still possible for us to cultivate shadows?” (Fisher 2018, p. 552)
Per uscire da questa prospettiva unica neoliberale che fa del merito un suo pilastro, è necessario prima di tutto disfarsi della lingua che lo alimenta e che ci inganna, per ricostruirne una le cui parole aderiscano alla realtà, svelandola. Per tornare a coltivare ombre, per attraversare il fallimento come primo passo verso un futuro diverso, intendendo questo fallimento come il fallire rispetto al paradigma del successo neoliberale ovvero (ri)scoprire forme diverse di esistenza, di realizzazione, di reale pienezza di vita.
“Anche il pensiero unico ha le sue periferie, i suoi colpi a vuoto, le sue mancanze. Tutto quello che sembra un fallire oggi è la nostra unica speranza.” (Arminio 2013, p. 33)
Riallacciare parole al reale: per una resistenza lessicale
Perché il fallimento, pur inteso nella sua accezione positiva e creativa spiegata qui sopra, non sia l’unico orizzonte possibile, quali parole possiamo mettere avanti in risposta, per tenere salde alcune idee di importanza fondamentale? Attraverso quali scelte lessicali possiamo riportare il linguaggio ad aderire alla realtà e a opporlo alla distorsione del significato imposta dalla “neolingua dell’economia”?
Voglio fare una semplice proposta lessicale, che possa essere indicazione di lavoro per costruire un bagaglio culturale, un vocabolario collettivo per resistere e per aprire nuovi percorsi verso il futuro. Tre parole per tre idee.
Conoscenza: etimologicamente (dal latino cum-gnoscere, a sua volta di derivazione greca), ci riporta all’idea di apprendere con l’intelletto. Apprendimento, quindi, ma anche uso dell’intelletto contro la dittatura delle emozioni che oggi domina i media, la società e anche la politica, che sia definita populista o meno, dato che il compito dei leader politici del nostro tempo “è rappresentare emozioni più che classi sociali, stati d’animo più che programmi di governo” (Tonello 2019, p. 55).
Disciplina: deriva da discepolo (dal latino discere: imparare). La capacità (e il desiderio) di imparare (che porta alla conoscenza) e insieme la capacità di apprendere da altri (il discepolo è sempre discepolo di qualcuno), includendo l’importanza della trasmissione dei saperi, cioè una dimensione relazionale, sociale. comunitaria. Ma anche nel senso di disciplina del sé, di misura, lontana però dall’idea di obbedienza (che, invece, etimologicamente, rimanda all’eseguire comandi di altri, al sottomettersi al loro volere).
Umiltà: da humus, terra. Tenersi radicati, umili, applicando la disciplina del sé contro la retorica della visibilità e del successo economico. Ma anche come legame con il pianeta, come rifiuto dell’antropocentrismo e dello sfruttamento capitalistico dell’umano e delle risorse della terra.
Radicare le parole nel reale, anche attraverso la loro etimologia, è un modo per riappropriarsene, per uscire dalla gabbia ideologica in cui siamo stati rinchiusi anche attraverso il linguaggio e tentare, così, di aprire nuove possibilità per il futuro.
Note
(1) http://www.treccani.it/vocabolario/competenza
(2) G. D’Alia, Self-branding. La retorica del successo contemporaneo, Rizomatica 02. https://rizomatica.noblogs.org/2020/05/self-branding/
(3) R. Laghi, “Indignados” in piazza anche a Bologna, MicroMega http://temi.repubblica.it/micromega-online/indignados-in-piazza-anche-a-bologna/
(4) Teresa Bellanova, Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, intervento alla Leopolda 10, 20 ottobre 2019, https://yewtu.be/watch?v=IJW6MiY6RHQ (min. 13:34)
(5) “Una stazione è un luogo in cui si incrociano le persone che riescono e quelle che non sono niente” (traduzione mia). Per un’analisi del discorso di Macron e di ciò che il suo linguaggio rappresenta, rimando a Mathieu Slama, Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien: ce que révèle la petite phrase de Macron, Le Figaro, 3.7.2017, https://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/07/03/31001-20170703ARTFIG00167-les-gens-qui-reussissent-et-les-gens-qui-ne-sont-rien-ce-que-revele-la-petite-phrase-de-macron.php
(6) Costituzione della Repubblica Italiana, https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
(7) Matthew Stewart, The 9.9 percent is the new American aristocracy, The Atlantic, June 2018 https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/the-birth-of-a-new-american-aristocracy/559130/
Bibliografia
Arminio, Franco, Geografia commossa dell’Italia interna, Mondadori, 2013.
Arminio, Franco, La cura dello sguardo., Bompiani, 2020.
Boarelli, Mauro, Contro l’ideologia del merito, Laterza, 2019, (ebook).
Fisher, Mark, K-Punk. The collected and unpublished writings of Mark Fisher (2004-2016), Repeater, 2018.
Fitoussi, Jean-Paul, La neolingua dell’economia, Einaudi, 2019.
Graeber, David, Bullshit jobs. The rise of pointless work and what we can do about it, Penguin, 2019.
Markovits, Daniel, The meritocracy trap. How America’s foundational myth feeds inequality, dismantle the middle class and devours the elite, Penguin, 2019,(ebook).
Sandage, Scott A., Born losers. A history of failure in America, Harvard University Press, 2005.
Tonello, Fabrizio, Democrazie a rischio. La produzione sociale dell’ignoranza, Pearson, 2019.
