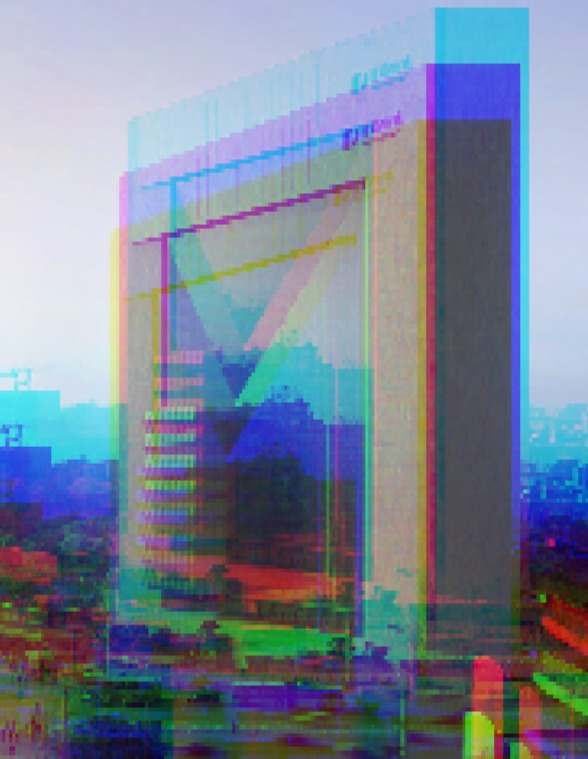G. D’Alia
Ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l’apparenza dell’ordine naturale, deve rivelare che quello che ci viene presentato come necessario e inevitabile altro non è che una contingenza.
[…]
L’unica maniera per mettere in discussione il realismo capitalista è mostrare in qualche modo quanto sia inconsistente e indifendibile: insomma, ribadire che di ‘realista’ il capitalismo non ha nulla. Mark Fisher, Realismo Capitalista
Abstract
A partire dall’analisi retorica delle strategie di self-branding digitale, il modello di successo contemporaneo verrà qui messo in relazione con le strutture socio-economiche del tardo capitalismo. Una volta storicizzata, la pratica del self-branding non apparirà più una semplice deriva narcisistica causata dalla cultura dei social network, ma si renderà evidente come essa sia piuttosto una conseguenza, sul piano culturale, dell’economia del lavoro precario. L’intento è quello di portare alla luce i messaggi impliciti nel flusso di comunicazione nel quale siamo immersi e del quale siamo parte, leggendoli alla luce della sociologia del lavoro. L’obiettivo generale è di comprendere la natura, a prescindere dal modo in cui rispondiamo personalmente, dell’invito che il contesto mediatico ansiosamente ci rinnova: sfoggiare contenuti personali, aggiornare con dedizione le numerose bacheche e sorvegliare la nostra footprint digitale, affinché rispecchi alla perfezione l’immagine ideale di noi stessi o, piuttosto, l’ologramma del lavoratore neoliberista perfetto, cioè iper-qualificato, efficiente, flessibile e, soprattutto, sempre motivato.
Il valore della visibilità
Nel 2017 la compagnia di viaggi inglese First Choice, parte del TUI Group (attualmente la più grande multinazionale del turismo al mondo, con sede in Germania), lancia un sondaggio rivolto ad un campione di 1000 individui, dai 6 ai 17 anni, ponendo loro una semplice domanda: “Cosa vuoi fare da grande?” Sul podio, dal primo al terzo, si sono posizionati: Youtuber, blogger/vlogger e musicista/cantante. Il campione preso in esame, di certo non esaustivo, funziona però bene come specchio su scala ridotta di tendenze in atto. Tra le motivazioni che spingono a desiderare questo tipo di professioni, gli intervistati hanno spiegato, ci sono la creatività, la fama e l’opportunità di esprimersi liberamente. L’opportunità di arricchirsi tramite queste attività, invece, risulta l’ultima delle motivazioni prese in considerazione. Il sondaggio suggerisce anche che le professioni tradizionali come quelle del medico, dell’avvocato e dell’insegnante abbiano perso attrattiva in confronto alle carriere promesse dall’industria dell’intrattenimento online, attestandosi sulle ultime posizioni della classifica.
L’interesse per i più giovani da parte della compagnia di viaggi First Choice è stato risvegliato da una vicenda modesta ma emblematica. La protagonista è Beth Ward, una bambina inglese di dieci anni, che nel 2017 ha inviato una mail all’agenzia di viaggi allegando un link al suo video delle vacanze pubblicato su Youtube. Il soggiorno presso il resort Azul Fives in Messico, organizzato da First Choice, è stato l’occasione per girare e montare un video, seguendo la sua passione per il grande schermo. Nella mail la bambina condivideva con entusiasmo il sogno di diventare un giorno regista. Il video ha fatto il giro degli uffici, arrivando fino a Nick Longman, il managing director di TUI UK e Ireland, il quale ha risposto direttamente a Beth facendole i complimenti. La First Choice ha così colto la palla al balzo per lucidare il suo brand e ha organizzato un’esclusiva masterclass di movie making solo per lei. A tenere l’indimenticabile lezione in uno studio di Londra è stato chiamato Martin Kemp, ex bassista degli Spandau Ballet, oggi anche produttore e attore tv. Dopo aver aiutato Beth ad aggiungere al suo video un po’ di “movie magic”, quest’ultimo si è recato nella cittadina natale di Beth, Darlington, nel nord-est del Regno Unito. Qui, d’accordo con gli insegnanti della Barley Fields Primary School, ha organizzato una piccola première del nuovo video delle vacanze, con tanto di tappeto rosso.
L’intera vicenda, sebbene su scala ridotta, ha prodotto visibilità in tutti i sensi: non solo ha accresciuto la reputazione della compagnia di viaggi e ha portato un po’ di attenzione su Kemp, ma ha anche contribuito ad aumentare una ‘visibilità strategica’ sugli orizzonti esistenziali della fascia d’età più giovane, quella alla quale appartiene Beth. Che anche lei abbia goduto degli apparenti benefici di questa vicenda, è quanto in un certo senso ci auguriamo ma a cui purtroppo non crediamo fino in fondo, trattandosi dell’anello più debole della catena. Dal 2017 il video di Beth è pubblicato sul canale Youtube di First Choice, con un titolo che sembra quasi una parodia: “First Choice and Martin Kemp turn little girl’s holiday film into a movie masterpiece” (1). Il desiderio di Beth è impiegato come spot pubblicitario, sebbene raggiunga poco più di 2.000 visualizzazioni. Anche la masterclass tenuta da Martin Kemp è diligentemente filmata e montata, creando così contenuti extra da caricare sul canale. Più che trattarsi di un ‘capolavoro cinematografico’, ovviamente, il video delle vacanze prodotto da Kemp si ispira ai video di travel vloggers e life-style influencers.
Attraverso il confezionamento di un’esperienza da sogno per Beth, infarcita di adulazioni, First Choice ha semplicemente perseguito i suoi scopi lungo un tracciato comune nell’economia degli affetti. In Capitalismo, desiderio, servitù (2010), Frédéric Lordon, ripartendo dall’antropologia di Spinoza, dà conto del meccanismo di creazione di valore in quella che definisce l’attuale economia delle passioni. Per convertire il lavoro in forza-lavoro, il regime del capitalismo contemporaneo ricorre ai desideri privati dei singoli, servendosi della spinta vitale che li sorregge per convertirla in profitto. Il meccanismo non ha nulla a che vedere con i desideri profondi degli individui, funzionando piuttosto come quel fungo parassitoide dalla straordinaria e spietata intelligenza che colonizza il corpo delle formiche per sprigionare le sue spore. Il corpo della formica, una volta utilizzato, viene distrutto in un modo piuttosto sgradevole che invito i più temerari a scoprire su Youtube cercando la parola chiave “cordyceps”. Se a molti, tra coloro che possono permetterselo, l’idea di lavorare e basta risulta decisamente poco attraente, lavorare divertendosi, o lavorare diventando famosi, risulta ben più appetibile. All’utilizzo dei corpi dei lavoratori, si aggiunge quello delle loro passioni. Nello scenario ultraliberista, l’architettura dello sfruttamento si fonda sull’individuo e sul suo desiderio.
Idols of promotion
Parallelamente all’ascesa di figure di spicco come Youtubers o Instagram influencers, negli anni recenti sono proliferati studi accademici per indagare la cultura della fama sui social media. C’è come una sorta di chiamata alle armi intellettuali nel mondo accademico, formulata nella richiesta di rinnovare l’attenzione sul ruolo che la comunicazione mediata gioca nel produrre soggettività nell’economia degli affetti. Particolarmente utile per collocare la vicenda Beth Ward e First Choice, è uno studio condotto nel 2019 da Brooke Erin Duffy e Jefferson Pooley, pubblicata sul Journal of Communication 69 edito dalla Oxford University Press. Gli autori hanno delineato nel dettaglio la figura del prosumer di successo, termine coniato nel 1980 dal futurista americano Alvin Toffler per riferirsi ai consumatori che diventano produttori nell’era di Internet. L’hanno però contestualizzata all’interno del web 2.0 e messa in relazione con i modelli di celebrità attualmente dominanti. Duffy e Pooley ripartono da un famoso studio condotto nel 1944 da Leo Lowenthal, sociologo della scuola di Francoforte. Lowenthal aveva indagato i modelli di successo veicolati dalla stampa di massa attraverso l’analisi delle biografie di personaggi famosi pubblicate sulle riviste. Egli aveva evidenziato come, se all’inizio del Novecento il modello di successo fosse rappresentato da self-made men sul tipo di industriali e politici, già nella metà degli anni Quaranta si registrava un decisivo spostamento a favore di star cinematografiche e atleti. Questo mutamento rispecchiava per Lowenthal il passaggio dall’economia della produzione all’economia del consumo. Entrambi i modelli economici generavano icone a loro immagine e somiglianza. Duffy e Pooley adattano lo stesso approccio di Lowenthal allo scenario mediale contemporaneo, prendendo in considerazione non più solo le biografie pubblicate sulle riviste, ma anche quelle sui social media (Instagram e Twitter). L’analisi qualitativa dei dati ha portato alla conclusione che il modello di successo contemporaneo si incarni in ‘icone della promozione’, un mix delle due tipologie identificate da Lowenthal: si tratta di prosumers, che provengono dalla sfera del consumo ma vengono descritti, e si descrivono, in termini produttivi. La storia di successo per eccellenza è la celebrazione del ‘coraggio promozionale’, quella capacità di mettersi in gioco che permette di affermarsi nell’economia del lavoro precario. La persona famosa viene considerata un medium, nel suo significato letterale: una figura cioè che si fa tramite di un messaggio (il contesto economico vigente) per il pubblico. Concretamente: le celebrità agli inizi del XXI secolo, gareggiando tra loro in una continua competizione per emergere, forniscono modelli di comportamento per gestire la propria immagine. Insegnano cioè al pubblico come fare self-branding per imprimersi nello scenario mediale. Il parziale azzerarsi delle distanze tra famosi e fans (promosso in parte dalle piattaforme social interattive, ma già iniziato con talk-shows e reality tv) velocizza questo lavoro di mediazione e facilita l’apprendimento per emulazione. Le icone della promozione sono gli eroi di due mondi: eroi del consumo, in quanto rappresentano le industrie dell’intrattenimento, dei media e dello sport; eroi della produzione, in quanto condividono i valori della produzione e del profitto, con la differenza che il profitto è generato da loro stessi, in quanto ciò che vendono è la loro identità. Già Lowenthal aveva compreso che l’idolatria è un’espressione del sistema economico dominante. Sulla scorta della sua intuizione, gli autori qui evidenziano che i resoconti – sia autobiografici che biografici – promossi dagli idoli contemporanei testimoniano il diffuso sentimento di ansia che caratterizza l’economia del lavoro precario. Per rispondere all’incertezza, il principio guida promosso dai discorsi e dalle pratiche neoliberiste è di orchestrare il più seriamente possibile il proprio ‘progetto di vita’. La responsabilità per il successo o il fallimento appartiene unicamente all’individuo (o così finiamo per credere). La costruzione dell’identità diviene qualcosa di più simile a un obbligo: una campagna militare, senza confini, instabile, condotta strenuamente da soli. Per Duffy e Pooley, l’esplosione della retorica del self-branding è connessa alla perturbante esperienza contemporanea del lavoro, un obbligatorio mettersi in proprio come unica possibilità per rimanere a galla nel mare in tempesta della società liquida. Le arti del self-branding praticate dalle celebrità contemporanee sono perciò lezioni performative, lezioni in atto di sopravvivenza in tempi vertiginosi. La parte più interessante della ricerca di Duffy e Pooley riguarda l’analisi del brand personale promossa dalle celebrità. A differenza di numerosi studi sul self-branding, infatti, non viene presa in esame la manualistica sull’argomento, ma come le celebrità ne incarnino il modello. Emergono tre aspetti tipici della retorica del successo: la promessa di meritocrazia, lo spirito di auto-imprenditorialità multi-piattaforma e la promozione dell’autenticità.
Meritocrazia per tutti, fallimenti e auto-imprenditorialità
All’alba del XXI secolo il successo è attribuito in modo preponderante al duro lavoro, al talento o alla combinazione di entrambi. Come le icone del mondo della produzione tratteggiate da Lowenthal, le icone della promozione contemporanea condividono la stessa retorica dell’impegno senza riserve e della conquista del successo a partire da umili origini. Il messaggio di questi e altri paradigmatici racconti è che il successo abbia meno a che fare con le coincidenze fortunate e più con l’olio di gomito e le abilità personali. La perseveranza è tra le qualità più celebrate, poiché necessaria ad affrontare gli ostacoli che si incontreranno lungo la strada. Rispetto alle storie di star del cinema o dello sport di metà Novecento, nelle quali spesso era un colpo di fortuna a strapparle all’anonimato, le celebrità contemporanee non aspettano passivamente una buona occasione per dimostrare il proprio valore, ma costruiscono da sole le condizioni del proprio successo. La minuziosa descrizione di sconfitte e rivincite di chi infine ottiene ciò per cui ha combattuto, che si tratti di riconoscimento professionale o di un corpo scultoreo, è tra gli argomenti più amati dai consumatori di riviste, blog motivazionali, profili Instagram e canali Youtube. Più che una fortuna gratuita, quindi, le parabole del successo descrivono un meritato stato di fortuna, visione legittimata dalla convinzione che l’individuo sia pienamente in possesso del proprio destino. In questa retorica fallimenti e rifiuti vengono feticizzati per dare risalto alla perseveranza. Il fallimento è ammesso, ma solo come tappa che precede e legittima il successo, come in tutte le narrazioni del viaggio dell’eroe che si rispettino. Se venisse a mancare il punto di arrivo, ovvero l’auto-realizzazione misurata in termini di fama o guadagno economico, il fallimento resterebbe fallimento e, come tale, non degno di attenzione. La sorte del precario o del disoccupato non sembra essere un aspetto processato dalla retorica del successo. Si tratta del suo tabù, che rivelerebbe le contraddizioni interne al sistema neoliberista di cui è la propaganda. Il ‘vero fallimento’ per la cultura tardo capitalista è non provare affatto, non essersi messi in gioco. Precari e disoccupati sarebbero tali poiché non hanno ancora provato abbastanza. Questa retorica evita astutamente di definirli ‘perdenti’, limitandosi a ribadire la promessa di un’imminente realizzazione esistenziale e professionale. Così facendo, anche gli individui più frustrati permangono nell’arena, inebriati di speranza e disperati di fronte alla prospettiva del fallimento. Ritirarsi dalla competizione sarebbe segno di debolezza o, in alternativa, significherebbe rinunciare alla realizzazione del proprio ‘potenziale’. Le nuove icone di successo esemplificano l’ansiosa esperienza dell’auto-produzione (self-making) che Beck (1992), Giddens (1991), e (con particolare acume) Bauman (2001, 2013) hanno articolato come qualità distintiva della modernità “tardiva”, “alta” o “liquida”. L’io riflessivo contemporaneo gode di una sorta di terrificante libertà, una dimensione esistenziale nella quale, da un lato, tutto il rischio economico e sociale dell’esposizione viene scaricato sul lavoratore mentre, dall’altro, il valore prodotto combattendo la battaglia digitale di self-branding gli viene sottratto dai meccanismi dell’economia dei dati.
Molti di noi sperimentano mercati del lavoro imprevedibili e a breve termine, per poter accedere ai quali bisogna mantenersi attivi su piattaforme digitali che fungono da palcoscenico, costretti a permanere sotto i riflettori, a misurarsi con giudizi e con provini che non finiscono mai. Lo svuotamento e l’impoverimento di strutture statali e comunitarie di sostegno comporta che una “cattiva” performance, per tutti tranne che per i più privilegiati, sia potenzialmente devastante e che, per tutto il tempo, la vita è competizione. Il prisma dell’auto-responsabilità, inoltre, comporta che i ‘perdenti’ della società siano gli unici a portare il peso (e l’umiliazione) del loro ‘fallimento’:
“[Se] rimangono disoccupati, è perché non sono riusciti ad apprendere le competenze necessarie per ottenere un colloquio, o perché non hanno provato abbastanza a cercare lavoro, o perché sono, semplicemente, dei timidi; se le loro prospettive di carriera sono incerte e il futuro li angoscia, è perché non sono abbastanza bravi a farsi degli amici e influenzare le persone e perché non sono stati in grado di apprendere e perfezionare, come avrebbero dovuto, le arti dell’auto-espressione e del fare colpo sugli altri.” (2) (Duffy e Pooley 2019, p. 42)
In questo scenario si colloca l’imperativo diffuso dell’auto-imprenditorialità, più efficace se multi-piattaforma. Quasi metà (91 su 189) dei profili Instagram e Twitter analizzati da Duffy e Pooley, inseriscono in bio un link che rimanda alla propria ultima impresa imprenditoriale: link al disco, link al libro, link alla propria linea di cosmetici, link all’ultima puntata su Netflix, link a… Pubblicità e spirito imprenditoriale sono alla base del self-branding digitale. Le icone della promozione contemporanee rivendicano acume per l’industria, celebrano il lavoro flessibile e la versatilità delle competenze. Lo stesso approccio sembra accomunare diversi settori lavorativi senza molte differenze, ma è senz’altro per gli operatori culturali che creatività e affari si sono mescolati senza soluzione di continuità. L’acume commerciale è ora integrato e attivamente incorporato nell’identità artistica.
Autenticità del calcolo: un difficile equilibrio
Se c’è un ritornello instancabilmente ripetuto tanto dalle celebrità che dai giornalisti che le intervistano, è che quello che ci viene mostrato è autentico. L’immagine che le star propongono di loro stessi, rassicurano tutti, è genuina. Lo Youtuber Tyler Oakley intervistato su Time dichiara che è meglio essere se stessi piuttosto che fingere di essere qualcun altro solo per essere più retwittabili (3). Questa retorica è la norma per le star dei social media, ma lo è anche per le star ‘di prima generazione’, come attori e cantanti. Il messaggio principale, in queste e in molte altre riviste del campione preso in esame da Duffy e Pooley, è che i personaggi famosi si siano allineati a “chi sono veramente” e possano finalmente essere sé stessi. L’idea che le star siano proprio come noi è da tempo un tema ricorsivo di tabloid e trasmissioni tv votate al gossip, ancor più oggi legittimato dall’interattività e dalla pseudo-intimità permesse dalla natura dei social network, che regalano incursioni off-screen nelle vite delle celebrità (senza trucco, in cucina, appena sveglie e così via). Nelle bio dei social, le star mediatizzate cercano di minimizzare il proprio statuto di celebrità mettendo l’accento sulla personalità lontana dai riflettori. Nella sua bio Instagram del 2017, Tom Hanks scrive: “I’m that actor in some of the movies you liked and some you didn’t”. Lo stesso vale per le bio dei personaggi del mondo politico. Hillary Clinton sinteticamente si descrive: “Wife, mom, grandma”.
Quello tra autenticità e calcolo pubblicitario è un difficile equilibrio che comporta un’imposizione paradossale: utilizzare l’onesta auto-espressione per condurre una strategica auto-promozione. Il richiamo all’autenticità affabile, in questo scenario, funziona come diversivo retorico. L’insistenza sull’io reale che si cela dietro il brand personale è la strategia necessaria per contrastare il naturale scetticismo che pur sempre permane nei confronti di tutto ciò che è promozionale. Condividendo ed elencando passioni, passatempi e interessi (non necessariamente limitati all’esperienza professionale, anzi), tanto le celebrità quanto i lavoratori freelance costruiscono l’invito a entrare in intimità con loro, a fare conoscenza e abbassare le barriere della diffidenza. Mettendosi in mostra invitano il fan o il potenziale cliente a fare lo stesso. Evitando di insistere su aspetti espliciti del marketing classico, come competitività dei prezzi o consigli promozionali, il self-branding trasforma l’auto-promozione in un’esperienza condivisa. L’engagement emotivo è condiviso, ma i guadagni sono personali – e così dev’essere necessariamente, nell’arena impietosa del mercato del lavoro in cui ognuno è costretto a pensare per sé. La scommessa implicita e paradossale nella retorica del self-branding è quella di mostrare una personalità autentica che ‘resiste’ all’inglobamento nel brand. In diverse proporzioni a seconda dello stile personale, la messa in scena del conflitto tra il sé e le logiche di mercato è quindi tipico delle migliori performance di self-branding. Il marketing 4.0, detto anche “marketing umanistico”, sa che il cliente non è più solo un cliente e che, anzi, pretende di essere trattato come un essere umano e non come un semplice portafogli. Il marketing umanistico è l’evoluzione che ci voleva per “conferire autenticità ai marchi trasformandoli in amici […] accessibili e gradevoli, ma a loro volta vulnerabili. I brand devono intimidire di meno. Devono diventare autentici e sinceri, ammettere i propri punti deboli e non fingersi perfetti. Imperniato su un sistema di valori, un brand umanistico tratta i clienti come amici, diventando parte integrante del loro stile di vita.” (Kotler 2017, p. 179)
L’economia chiede ai lavoratori di vendere se stessi e il suo consiglio ha una logica interna: coltivare una personalità autentica, o metterla in scena, è una forma di creazione di valore affettivo che, suscitando un buon livello di coinvolgimento, può condurre a ricevere offerte, promozioni e altre forme di guadagno individuale, in linea con la logica della prestazione che dispensa premi ai più bravi. Le icone della promozione danno sfoggio di abilità pubblicitaria, invitando i followers (lavoratori precari) a seguirne l’esempio, creando oasi di micro-celebrità per accrescere reputazione sociale e possibilità di impiego.
Perché dovremmo scegliere te?
Accade sempre più spesso che gli studi sulla celebrità e la cultura popolare abbiano a che fare con la sociologia del lavoro. Ciò avviene perché l’identità che progettiamo e mettiamo in scena attraverso il nostro comportamento sui social non è più solo un affare personale ma è a tutti gli effetti un affare pubblico, divenendo il nostro biglietto da visita per il prossimo datore di lavoro. La costruzione della soggettività digitale e i processi della sua comunicazione risultano in larga parte condizionati dagli stessi meccanismi di reclutamento della forza-lavoro tipici delle aziende. I criteri di valutazione messi in atto dagli uffici risorse umane sembrano preventivamente incorporati nelle strategie di self-branding digitale. Oltre allo sfoggio delle nostre competenze, siamo invitati a dare spettacolo di una costante motivazione, a mostrare quanto arde il nostro desiderio (di essere, di fare) e quanto la nostra identità vi sia allineata. Per condurre una buona strategia di self-branding, “Forbes” online consiglia di essere “coerenti” e di “vivere il proprio brand”, ovvero di fare in modo che il nostro stile di vita rispecchi fedelmente ciò che raccontiamo di noi e viceversa, poiché il brand personale deve essere “un’autentica manifestazione della tua identità e amplificare i valori in cui credi” (4) (Chan, 2018). La motivazione, soprattutto, conta ancor più delle competenze tecniche, che potranno eventualmente essere apprese all’interno dell’azienda una volta superato il colloquio. Ogni datore di lavoro ha bisogno prima di tutto di sondare l’irriducibile mistero dell’identità del candidato: “Che cosa ama davvero? Cos’è che lo spinge? Ciò di cui noi ci occupiamo lo attrae davvero?”. Si chiede se valga la pena investire nell’assunzione di quel candidato piuttosto che di un altro, e tutti gli aspiranti conoscono il peso di tale incertezza. Questo vale ancor più nel contesto neoliberista dove il datore di lavoro tende sempre meno ad assumersi il rischio economico dell’assunzione, scaricando comunque sul lavoratore il peso delle fluttuazioni del mercato. Ogni assunzione pesa come un investimento e va, pertanto, debitamente ponderata. Tutti i candidati dunque sanno, in partenza, di dover adottare la medesima strategia motivazionale per guadagnarsi la fiducia del datore di lavoro, quella “dichiarazione preventiva di interesse” che per Frédéric Lordon è “una specie di minimo sindacale del proclama di conformità di desiderio – sono fortemente interessato, mi interessa moltissimo…” (2010, p. 112). In questo senso, là dove si incontrano la costruzione dell’identità digitale con le pratiche valutative e selettive del mercato del lavoro, si manifesta a pieno la società capitalistica in cui viviamo, i cui membri, prima ancora che persone libere, sono chiamate ad essere liberi imprenditori di se stessi.
Una lezione ereditata da Lowenthal è che i fenomeni mediatici, come la celebrità, sono inseparabili dal contesto economico e sociale che li produce, funzionando da cartina al tornasole dei valori promossi dalle strutture che governano la vita di tutti i giorni. Il punto in questo caso non è abbracciare un semplice riduzionismo, come se nella corsa all’affermazione i valori non incontrassero resistenza alcuna da parte degli individui. Si tratta piuttosto di familiarizzare con l’idea della reciprocità tra le industrie dello storytelling e le macro-tendenze socio-economiche. L’adattamento dell’individuo contemporaneo al self-branding e, più in generale, alla cultura manageriale, non è affatto pacifico o privo di conflitti come molte delle letture offerte di questo fenomeno lascerebbero intendere. Lo studio di Michal Pagis e Galit Ailon, pubblicato nel 2017 sulla rivista “Work and Occupations”, fa riflettere su quest’aspetto. I ricercatori hanno preso in esame le pagine web di 100 auto dichiarati esperti di settore e consulenti, sia professionali che semi-professionali, nei campi più disparati: marketing, management, musica, media e sviluppo delle competenze sociali. Ne hanno concluso che nella messa in pratica degli insegnamenti proposti sia dalla manualistica motivazionale, che dalle ‘icone della promozione’, i lavoratori manifestino una sottile resistenza nell’applicare i principi del mercato alla narrazione personale. Se la retorica generale invita a insistere su tre aspetti principali quali la costruzione dell’unicità, la socievolezza e l’autenticità, dall’analisi stilistica emerge la tendenza dei consulenti ad attribuire tali caratteristiche al proprio sé, nel tentativo di differenziarsi dall’immagine del ‘mercato’. La propria identità viene a rappresentare ciò che è autentico, genuino, intimo, mentre il mercato viene associato a competitività, utilitarismo, inautenticità. Sebbene il tentativo di ribadire le proprie ‘buone intenzioni’ risulti paradossale e contraddittorio, dal momento che lo scopo è evidentemente promozionale e l’esposizione della soggettività online è in questi casi orientata al mercato, la tendenza testimonia perlomeno l’esistenza di una tensione. Tuttavia, questa tenue resistenza linguistica al processo di mercificazione è già diventata una delle convenzioni retoriche e stilistiche del self-branding. Come scriveva Mark Fisher, “il capitalismo è molto simile alla Cosa di John Carpenter: un’entità mostruosa, plastica e infinita capace di metabolizzare e assorbire qualsiasi oggetto con cui entra in contatto.” (2009, p. 33)
In conclusione, le competenze retoriche e linguistiche richieste per emergere nell’arena dei self-branders non sono affatto alla portata di tutti. Le operazioni svolte per promuoversi in modo affidabile, ovvero sfruttare il marketing pur non allineandosi passivamente al suo linguaggio, dare prova di empatia, creatività e ironia, si rivelano complesse e sofisticate. Risulta quanto conti, nel mercato contemporaneo del lavoro, possedere competenze linguistiche di alto livello e capacità riflessive. Una tale constatazione solleva una domanda circa la possibilità di apprendere (in quali occasioni e come) tali competenze, che richiedono un capitale culturale di partenza non certo accessibile a tutti. La narrazione della meritocrazia democratica rivela qui la fallacia delle sue premesse.
Self-Branding
Le tecniche di self-branding non nascono dal nulla ma affondano le radici in una terra di mezzo tra la letteratura di self-help e le teorie più aggiornate di marketing. I manuali di self-help si affacciano sul mercato librario già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, dispensando buoni consigli su come costruirsi una buona reputazione ed ottenere successo nella vita pubblica e negli affari, e sono inizialmente soprattutto espressione del pensiero liberale. Già nel 1859 in Scozia, Samuel Smiles pubblicava il libro Self-Help, considerato a posteriori la bibbia del liberalismo medio-vittoriano e tradotto in tutte le principali lingue europee, nonché in arabo, turco e giapponese. Per comprendere la natura motivazionale del testo, bisogna contestualizzarlo nell’ambito dell’impegno di Smiles per promuovere l’educazione della classe operaia. Sollecitato da una locale società di mutuo soccorso, nel 1845 l’autore tenne un discorso ad una classe serale, successivamente pubblicato con il titolo The Education of the Working Classes, che costituì di fatto il nucleo del futuro best-seller Self-Help. Il cuore della sua visione può cogliersi in un passaggio tratto da quel primo intervento, nel quale sosteneva che:
Ogni essere umano ha un’importante missione da compiere, nobili capacità da coltivare, un grande destino da realizzare. Dovrebbe avere accesso all’educazione e ai mezzi per impiegare liberamente l’energia che deriva dalla sua natura divina.” (5)
Smiles sosteneva che parsimonia, dedizione e perseveranza fossero le virtù che avrebbero permesso all’individuo di emanciparsi, in osservanza al motto: “Aiutati, che Dio t’aiuta!”. Il titolo di una traduzione italiana del 1880, già alla sua tredecesima ristampa, era infatti il lunghissimo: Chi si aiuta Dio l’aiuta, ovvero: storia degli uomini che dal nulla seppero innalzarsi ai più alti gradi in tutti i rami della umana attività. Smiles ebbe immediati epigoni, a partire dagli Stati Uniti. A seguito dell’istantaneo successo editoriale di Pushing to the Front (un libro apprezzato da personalità come Theodore Roosevelt, Thomas Edison e J. P. Morgan), l’americano Orison Swett Marden fondò nel 1897 la rivista “Success”, che raggiunse il mezzo milione di abbonati dispensando virtù e buon senso per realizzare una vita di successo a tutto tondo. La prospettiva dell’autore, influenzata oltre che da Smiles anche da Ralph Waldo Emerson (un autore molto citato dagli autori motivazionali contemporanei), richiama in molti punti una corrente di pensiero denominata “New Thought”, diffusasi a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in America, che si basava su una concezione positivista e individualista della vita, venata di un certo spiritualismo a tratti ambiguo. Secondo i pensatori del “New Thought Movement”, il successo personale si ottiene facendo leva sul pensiero positivo. Anche il successo finanziario, per Orison Swett Marden, è direttamente proporzionale all’investimento dell’individuo nello sviluppo delle proprie potenzialità. In altre parole, le circostanze esterne (biologiche, familiari, sociali, economiche) influenzeranno la vita delle persone tanto quanto saranno loro stesse a permetterlo. Nello stile conciso e diretto che divenne subito il tratto distintivo del genere, Swett Marden sosteneva:
“L’occasione d’oro che stai cercando è dentro di te. Non è nel tuo ambiente; non è nella fortuna o nell’occasione, né nell’aiuto degli altri; è solamente in te stesso.” (6)
Così la forza di volontà viene investita di sommi poteri, facendo di fatto piazza pulita di differenze e specificità. L’individuo a cui si rivolgono i discorsi motivazionali, tutto sommato, è astratto e idealizzato. Non importa se sei donna o uomo, se sei nato povero o ricco, sano o malato, o in quale parte del mondo. Tutto ciò che devi fare è rimboccarti le maniche e seguire dei validi esempi. Tutti gli esseri umani sono creati uguali tra loro e il creatore li dota di eguali diritti alla vita, alla libertà e, nella variante americana, alla ricerca della felicità. Sta pertanto ad ognuno, singolarmente, darsi da fare per conquistarsi ciò che gli spetta. L’impegno che infonderà nelle sue imprese e il valore che mostrerà di avere, determineranno, oltre che la sua reputazione sociale, il suo destino.
Nel 2011 la casa editrice Simon & Schuster pubblica una versione aggiornata al web 2.0 del manuale di self-help più venduto di tutti i tempi: How to Win Friends and Influence People di Dale Carnegie, che sempre nel 2011 la rivista “Times” collocava al diaciannovesimo posto nella lista dei cento libri più influenti di sempre. La nuova edizione adatta al nuovo millennio i “consigli senza tempo” pubblicati per la prima volta nel 1936, aggiornandoli all’epoca digitale e globale, rendendo con ciò evidente il filo rosso che collega la tradizione del self-help alle necessità dell’attuale società tardo capitalista.
Non serve comunque setacciare Internet per trovare qualche buon consiglio di auto-imprenditorialità contemporanea. Qualsiasi motore di ricerca si usi, gli articoli di “Forbes” sul self-branding, ad esempio, risultano ben indicizzati. L’arcinoto business magazine americano pullula di articoli dedicati alla costruzione del brand personale, di cui si parla con maggiore insistenza a partire dal 2010. Scorrendo le pagine, si incontrano tutte le parole chiave dell’universo self-help: perseveranza, impegno, coraggio, volontà. Si tratta di ipnotici advices&tips, riassunti in liste da dieci punti, che intendono placare l’ansia fornendo regole chiare, piani d’attacco e strategie per rischiarare la notte del lavoratore indipendente. Se alla prima impressione potrebbe sembrare che nulla sia cambiato dai tempi di Smiles, Swett Marden e Carnegie, bisogna rileggere i consigli sul web alla luce dei fenomeni che hanno radicalmente trasformato lo scenario socio-economico contemporaneo. La ristrutturazione postfordista del mercato del lavoro e il progressivo smantellamento del welfare state hanno lasciato i lavoratori pressoché sprovvisti di reti protettive. Tutti i professionisti, a prescindere dal campo di appartenenza, sono portati a servirsi di strategie auto-imprenditoriali per rimanere a galla nell’attuale scenario economico.
In questa prospettiva il self-branding si inserisce come la proposta culturale neoliberista per affrontare lo spaesamento. Secondo il già citato studio di Duffy e Pooley (2019), la mentalità manageriale si è diffusa nel mondo del lavoro in risposta alla crescente ansia causata dal senso di precarietà vissuta da individui isolati. Nel corso della seconda metà del Novecento, intanto, il settore dei servizi e dell’informazione si è popolato di industrie già adattate all’economia indipendente, che hanno posto le premesse della contemporanea gig-economy, caratterizzata dal lavoro part-time, frammentario e freelance, che può essere letta quindi come un’intensificazione di dinamiche di mercato già esistenti, favorite dall’onda dell’innovazione digitale.
Il self-branding fiorisce quindi sul finire del XX secolo, come parte integrante della svolta organizzativa del mercato del lavoro verso la “cultura d’impresa” (Du Gay 1995) e dell’instabilità delle assunzioni che ne è derivata. In seguito ai numerosi ridimensionamenti delle corporazioni, molti professionisti hanno perso o hanno lasciato i loro posti fissi reinventandosi come “esperti itineranti” (Barley e Kunda 2006) o “società di una sola persona” (Lane 2011), vendendo i propri servizi ‘porta a porta’, cioè organizzando corsi e conferenze o, cavalcando il web 2.0, intercettando gli utenti tramite blog e social network. Il lavoro autonomo è quindi riemerso come espressione primaria di un regime più globalizzato e flessibile di accumulazione capitalistica (Reed 1996).
Arrivati alla fine degli anni Novanta, il guru del management Tom Peters incoraggiava i lettori di “Fast Company” a pensare se stessi come “CEO di Me, Inc.”. Poco dopo, la rivista “Wired”, libri come Free Agent Nation. The Future of Working For Yourself (Daniel H. Pink, 2001) e consigli pubblicati su Internet celebrano la precarietà come flessibilità del libero professionista. Il messaggio generale di questi testi era quello di abbracciare l’incertezza e di cogliere l’opportunità di (ri)scrivere la propria carriera. “Si tratta di realizzazione. Si tratta di libertà. Si tratta del tuo tempo”, recita il retro di copertina di Free Agent Nation per incoraggiare i lettori a seguire l’esempio delle nuove icone, quei “pionieri del XXI secolo” che costruiscono vite più ricche in termini di senso e di introiti. Anche se al posto di ‘vite’, bisognerebbe ricordarsi di leggere ‘professioni’. Ma è proprio l’assimilazione dei due termini a dettare l’approccio: non si tratta più solo di lavoro ma di vita. Il lavoro è vita, la vita è lavoro – lavoro nel senso più aggressivo del termine. O meglio, tra le due dimensioni non esiste più un confine, sicché la vita è assoggettata alla concorrenza. Questa manageriale ‘chiamata alle armi’ di nuovi lavoratori-imprenditori di se stessi è oltretutto rivolta con enfasi a donne e a pensionati. Secondo Pink, le “mompreneurs” possono finalmente conquistarsi il riconoscimento che si meritano (secondo la sua acuta logica, basta mettersi in proprio per aggirare il maschilismo sul posto di lavoro) e chi è andato in pensione può rifiorire dando vita a una nuova, entusiasmante impresa manageriale. Nel frattempo l’affacciarsi sulla scena di Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram, ha semplicemente fornito al lavoratore i mezzi comunicativi per l’auto-espressione strategica all’interno dell’economia della reputazione guidata dalla misurazione, dove il successo è quantificabile in likes e visualizzazioni e si traduce in offerte di collaborazioni lavorative o richieste di servizi. In questo sistema, i lavoratori di tutti i settori sono stimolati a gestire lo spazio dei social network come fosse suolo pubblico, sul quale proporre contenuti ‘intimi’ che esprimano il loro ‘autentico’ brand personale. Come sosteneva Mark Fisher:
“Nel corso di più di trent’anni il realismo capitalista ha imposto con successo una specie di ‘ontologia imprenditoriale’ per la quale è semplicemente ovvio che tutto, dalla salute all’educazione, andrebbe gestito come un’azienda.” (2009, p. 51)
Compresa l’identità. L’enfasi contemporanea sulla narrazione personale, sulle competenze relazionali e sull’intimità delle persone, plasma quindi nuove forme di lavoro “immateriale” e “affettivo” (Hardt e Negri, 2009), che richiedono capitale culturale e competenze che non sono affatto possedute da tutti. Quella retorica liberale di fine Ottocento, che si rivolgeva agli uomini creati tutti uguali e dotati di eguali potenzialità, una visione che ancora smielatamente informa l’attuale retorica del self-branding, stride acutamente con opposti dati di fatto. Le disuguaglianze tra gli uomini nella società tardo capitalista sono strutturali e riguardano ancora differenze economiche, geografiche, di genere e di accesso a quegli strumenti considerati necessari a ‘mettersi in proprio’. Le strategie di self-branding sono confezionate per chi i mezzi già li ha e, coerentemente con la mentalità imprenditoriale, il problema di quanti i mezzi non li possiedono e soprattutto perché non li possiedano, di certo non le riguarda.
Scompensi psicologici
L’emergere di un ‘soggetto prestazionale’ con i suoi lati oscuri è quanto hanno descritto benissimo Federico Chicchi e Anna Simone in La società della prestazione (2017). Il modello di umanità neoliberista si basa sulla stessa responsabilità dell’iniziativa personale già presente nella retorica motivazionale di fine Ottocento. Con la differenza che se allora si era anche agli esordi dell’espansione di dottrine politiche sociali, oggi invece l’individuo è rimasto completamente solo nell’impresa, mentre per guadagnarsi un reddito sembra che non possa prescindere dal costruirsi e mantenere una certa reputazione digitale. Così i Daniel Blake della società, quell’operaio sessantenne non digitalizzato protagonista dell’omonimo film di Ken Loach (2016), restano esclusi da un sistema che vuole tutti smart e su di giri, in un modo o nell’altro obbligati al culto della prestazione sociale. Lettere motivazionali e portfolio delle competenze, meglio se confezionati con accattivante design, sono il perfetto esempio del capitale umano, relazionale e sociale richiesto a ciascuno come necessario biglietto d’ingresso nel cosiddetto ‘mondo del lavoro’. Nella fusione di lavoro e vita, ognuno è chiamato a spogliarsi della propria identità sociale in nome di una autenticità costruita seguendo i consigli dei manuali: l’unica autenticità ammessa è quella omologata e spendibile sul mercato.
Soggetti sempre più instabili e separati gli uni dagli altri, gli ‘aspiranti’ lavoratori contemporanei sono oggetto di costanti valutazioni selettive, in quello che Rosalind Gill (2010) ha definito un ‘never-ending pitch’ (campo da gioco, sfida, provino) e le enormi pressioni interne, unite all’insufficiente rete sociale di sostegno, rischiano di portarli al collasso per implosione. Nel 2009 Mark Fisher sosteneva la necessità di politicizzare i disordini mentali, soprattutto quelli considerati più comuni, come sindromi depressive, diffusi stati d’ansia, stress e angoscia. Invece di accettare la generalizzata privatizzazione dello stress, facendo ricadere interamente sugli individui la responsabilità dei loro problemi psicologici, Fisher ci ricorda che dovremmo piuttosto leggere l’impennata di tali disturbi come l’evidenza che “il capitalismo sia innatamente disfunzionale” (2009, p. 56). L’epidemia di stress emotivo denunciata da Oliver James nel 2009 in The Selfish Capitalist è l’altro lato della medaglia della società ultraliberista, in cui al posto di ricchezza e benessere per tutti non rimangono che ansia, frustrazione e lavoro precario.
La cultura del self-branding ha sostenuto la diffusione di un modello ideale di lavoratore, tratteggiato come “un aggressivo libero professionista, ricco di risorse, inventiva e creatività, in grado di muoversi agilmente in un mercato del lavoro fluttuante, pronto a cogliere qualsiasi opportunità di lavoro, ad auto-motivarsi e auto-promuoversi” senza sosta (Lair e altri, 2005). Questa tipologia di lavoratore è diventata anche sinonimo di uno stile di vita, al quale dovrebbe ambire la persona integrata e normale. ‘Flessibilità’, ‘nomadismo’ e ‘spontaneità’ non sono affatto un problema in sé ma lo diventano se interpretati come i valori rigidi di una forma di vita orientata unicamente al mercato. Se introiettato come unica possibilità esistenziale, il modello del lavoratore flessibile e aggressivo può divenire il riferimento per uno sfiancante confronto interno, uno specchio nero nel cui riflesso non tutti riescono a identificarsi placidamente. Il costante paragonarsi e scoprirsi insufficienti rispetto al modello ideale, cioè all’immaginario esistenziale collettivo, genera un ricircolo di frustrazione che trova sfogo nell’aggressività rivolta verso l’esterno (competizione con gli altri) o verso l’interno (autosvalutazione).
Già nel 1998 il sociologo francese Alain Ehrenberg aveva intuito la correlazione tra depressione e società contemporanea, sottolineando come dalla metà degli anni Ottanta la medicina del lavoro e le ricerche sociologiche registrassero il costante aumento di ansia, disturbi psicosomatici e depressioni. Sebbene il credo della società neoliberista voglia che ognuno parta alla conquista di se stesso, tuttavia l’ideale di un soggetto pieno, privo di crepe interne, che accresce il suo ‘potenziale umano’, riposa su una visione deficitaria dell’individuo, cioè sempre mancante rispetto a una norma. L’ipotesi avanzata da Ehrenberg è che la depressione sia la patologia di una società in cui la norma si fonda sulla responsabilità e l’iniziativa, intese esclusivamente in termini economici. Lacerato tra il diritto di scegliere la propria vita e il pressante dovere di ‘diventare se stessi’, del quale viene offerto un tracciato sul modello manageriale, l’individuo contemporaneo si confronta con una patologia dell’insufficienza, finendo per viverla come colpa privata. L’apparente assenza di obblighi e confini, unita alla pressante richiesta di mostrare ambizione, lo mette in crisi. Egli non sa cosa scegliere, perché sente di doversi assumere la responsabilità di “scegliere tutto e decidere tutto”. Il peso del possibile paralizza la volontà, degenerando in sindromi depressive che esprimono l’impossibilità stessa del vivere. A scontare il peso del mito della sovranità individuale è quindi il corpo del depresso, che si dibatte tra tristezza, inibizione e rallentamento psicomotorio, vivendo in un tempo senza futuro. “L’iniziativa individuale appare, all’individuo, una condizione indispensabile per continuare a vivere nel sociale. L’inibizione e l’impulsività, il vuoto dell’apatia e il recupero a base di stimolanti lo seguono come un’ombra.” (Ehrenberg 1998, p. 312). L’ossessione dell’auto-realizzazione esistenziale solleva dubbi circa una presunta ‘vera identità’ da cercare e conquistare. L’imperativo contemporaneo tradisce però l’illusione soggettivista da cui parte: quella convinzione, cioè, che l’individuo sia l’origine dei suoi desideri, l’artefice del proprio destino, nonostante le cause remote di ciò che desidera gli restino opache. La retorica dell’individualismo pratica spesso la rimozione, rifiutando l’ipotesi che l’individuo sia meno potente di quanto gli piaccia credere:
“L’ordine fortuito degli incontri e le leggi della vita affettiva attraverso i quali questi incontri […] producono i loro effetti fanno dell’uomo un automa passionale. Evidentemente, tutto il pensiero individualista-soggettivista, costruito intorno all’idea della volontà libera come controllo sovrano di sé, rifiuta in toto e con tutte le forze tale verdetto di radicale eteronomia.” (Lordon, 2015, p. 32)
Presa come metafora, la depressione in quanto patologia della libertà e dell’azione, dimostra quanto caro sia il prezzo da pagare per l’illusione di onnipotenza. In assenza di una vocazione personale alla quale aderire senza riserve, l’individuo si consuma in una ricerca potenzialmente infinita. La promessa dell’auto-realizzazione viene costantemente tradita, poiché sebbene sia facile proclamare che tutti abbiano il diritto di seguire la propria vocazione, nessuno può dire ad un altro in cosa essa consista. A ciascuno spetta il compito di progettare la sua vita. L’individuo scopre allora che all’alleggerirsi dei vincoli esterni non corrisponde affatto una ‘ritrovata’ sovranità individuale, quanto piuttosto un aumento di pesi da scontare nella dimensione privata. L’anelito ad essere se stessi si è trasformato nella “fatica di essere se stessi” e la retorica del successo riposa sulla chimera della conquista.
Note
-
First Choice and Martin Kemp turn little girl’s holiday film into a movie masterpiece, Youtube, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=gvDm1uczXi8&feature=emb_logo
-
Brano originale: “[If they] stay unemployed, it is because they failed to learn the skills of gaining an interview, or because they did not try hard enough to find a job or because they are, purely and simply, work-shy; if they are not sure about their career prospects and agonize about their future, it is because they are not good enough at winning friends and influencing people and failed to learn and master, as they should have done, the arts of self-expression and impressing the other.” (Duffy e Pooley, 2019, p. 42)
-
D. D’Addario, Tyler Oakley on how he became a social-media star: It’s not in my interest to change who I am, “Time”, 58, 2015
-
“Your personal brand should follow you everywhere you go. It needs to be an authentic manifestation of who you are and amplify what you believe.” G. Chan, 10 Golden Rules of Personal Branding, Forbes.com, 2018 https://www.forbes.com/sites/goldiechan/2018/11/08/10-golden-rules-personal-branding/
-
“Every human being has a great mission to perform, noble faculties to cultivate, a vast destiny to accomplish. He should have the means of education, and of exerting freely all the powers of his godlike nature.” (cit. in A. Smiles, Samuel Smiles and His Surroundings, 1956)
-
“The golden opportunity you are seeking is in yourself. It is not in your environment; it is not in luck or chance, or the help of others; it is in yourself alone.” https://www.brainyquote.com/quotes/orison_swett_marden_101086
Bibliografia
L. Lowenthal, Biographies in popular magazines, in (a cura di) P. F. Lazarsfeld & F. Stanton, Radio research, 1942–43, (pp. 507–548), Duell, Sloan, and Pearce, New York, 1944
A. Giddens, Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age, Stanford University Press, Stanford, 1991
U. Beck, Risk society: Towards a new modernity, Sagebeck, London, 1992
P. Du Gay, Consumption and identity at work, Sage, London, 1995
M. I. Reed, Expert power and control in late modernity: An empirical review and theoretical synthesis in “Organization Studies”, 17, pp. 573–597, 1996
A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, Einaudi, Torino, 1999
Z. Bauman, Consuming life, in “Journal of Consumer Culture”, 1(1), pp. 9–29, 2001
D. J. Lair, K. Sullivan, G. Cheney, Marketization and the recasting of the professional self: The rhetoric and ethics of personal branding, in “Management Communication Quarterly”, 18, pp. 307–343, 2005
S. R. Barley, G. Kunda, Gurus, hired guns, and warm bodies: Itinerant experts in a knowledge economy, Princeton University Press, Princeton, 2006
M. Hardt, A. Negri, Empire, Harvard University Press, Boston, 2009
M. Fisher, Capitalist Realism. Is there no alternative?, Zero Books, 2009, ed. it. Realismo capitalista, NERO, 2018
R. Gill, Life is a pitch: Managing the self in new media work, in M. Deuze (a cura di) Managing media work, pp. 249–262, Sage Publications, London, 2010
F. Lordon, Captalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010, ed. it. Capitalismo, desiderio e servitù. Antropologia delle passioni nel lavoro contemporaneo, DeriveApprodi, Roma, 2015
C. M. Lane, A company of one: Insecurity, independence, and the new world of white-collar unemployment, Cornell University Press, Ithaca, 2011
D. Carnegie & Associates, How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, Simon & Schuster, 2011
Z. Bauman, Liquid times: Living in an age of uncertainty, Polity, Cambridge, 2013
D. D’Addario, Tyler Oakley on how he became a social-media star: ’It’s not in my interest to change who I am’, Time, 58, 2015
F. Chicchi, A. Simone La società della prestazione, Ediesse, Roma, 2017
P. Kotler, Marketing 4.0. Dal tradizionale al digitale, Hoepli, Milano, 2017
M. Pagis, G. Ailon, The Paradoxes of Self-Branding. An Analysis of Consultant’s Professional Web Pages, in “Work and Occupation”, 44 (3), pp. 243-267, 2017
P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 4.0: dal tradizionale al digitale, Ulrico Hoepli Editore, epub, 2017
G. Chan, 10 Golden Rules of Personal Branding, Forbes.com, 2018
B. E. Duffy, J. Pooley, Idols of Promotion: the Triumph of Self-Branding in an Age of Precarity, in “Journal of Communication”, 69, pp. 126-48, 2019