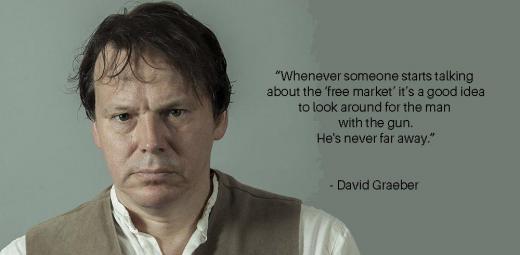 Pubblicato in origine il 5-09-2020 su Effimera di F. Berardi (Bifo)
Pubblicato in origine il 5-09-2020 su Effimera di F. Berardi (Bifo)
Conobbi David a Sapporo, nell’anno 2008 nella palestra dove si teneva la riunione iniziale delle giornate di contro-summit, mentre il G8 si riuniva in qualche luogo iper-protetto della città capitale dell’Hokkaido. Eravamo arrivati da poche ore, io e Claudia dall’Italia, David da Londra, e avevamo un sonno bestiale. Mentre i compagni giapponesi facevano i discorsini introduttivi al contro-summit, David si stese per terra e si addormentò per un po’.
Quando la riunione si concluse lui si alzò tutto stropicciato e ce ne andammo all’Hotel dove eravamo ospitati, o per meglio dire inscatolati. Ma la sera bussò alla nostra porta e ci chiese se avevamo qualcosa contro il mal di pancia. Avevamo quel che occorreva e lui si fermò per un’oretta a raccontarci quando era stato in Madagascar, e la percezione del tempo nella cultura africana e il fatto che è inutile darsi appuntamento qui o là tanto nessuno va mai agli appuntamenti, si dice tanto per dire allora ci vediamo alle tre al caffè, poi è inutile che ci vai tanto non ci trovi nessuno. Magari puoi fermarti lì in attesa che prima o poi quello con cui avevi preso appuntamento passi di lì casualmente e allora sai che festa, che gioia, che fortuna vederti.
Nel settembre del 2008 (ci conoscevamo da poco) mentre crollava la Lehman Brothers e altri colossi barcollavano, David mi mandò un messaggio che diceva: Non so se ho le traveggole ma mi sembra di capire che il capitalismo è finito.
Poi ci rivedemmo a New York con il nostro comune amico Sabu Kosho. E poi ci rivedemmo a Londra un paio di volte. L’ultima volta che ci siamo visti è stato un anno fa. E’ venuto a Bologna con Nika, e io li ho portati a vedere il Compianto di Niccolò dell’Arca nella chiesa di Santa Maria della Vita.
E gli ho raccontato che durante la grande peste del seicento quelli che scampavano la morte qui venivano a render grazia. Scendevano le scale lì di fronte, scendevano giù dal Portico della Morte dove si trovava il lazzaretto e adesso si trova la libreria Nanni.
Adesso mi dicono che è morto e in un primo momento è stato un po’ come ricevere una bastonata in fronte. E invece sì, se n’è andato anche lui.
Il suo stile di pensiero è inconfondibile e decisivo: con allegria filosofica ha dimostrato che il capitalismo non c’è più, è rimasto solo il suo scheletro, una gabbia in cui è stata intrappolata la società umana. Il debito è l’esempio principe di questo intrappolamento del concreto da parte dell’astratto.
David non è un economista, è un antropologo, e solo dal punto di vista dell’antropologo, colui che si concentra sulle forme della vita e sulle forme epistemiche, si può guardare la gabbia dall’esterno.
Gli economisti non sanno vedere la realtà, perché le loro categorie sono le sbarre di quella gabbia. E’ l’antropologo che possiede la chiave che permette di uscire, e di guardare finalmente la gabbia dall’esterno, e che permette di capire che un esterno c’è, anche se non è certo che riusciremo mai ad abitarlo.
L’esterno è l’esistere, l’esperire immediato, l’esterno è la mortalità, il divenire nulla
Riproponiamo qui sotto un articolo di David pubblicato da Liberation
* * * * *
Verso una “economia di merda” – di David Graeber
In Inghilterra e negli Stati Uniti si parla continuamente, tra le altre espressioni dello stesso tipo, della necessità di “rilanciare l’economia”, di “far ripartire la nostra economia in modo che possa funzionare a pieno regime”. Queste frasi danno l’impressione che l’economia sia una sorta di enorme turbina che è stata temporaneamente spenta e che ha bisogno di essere rimessa in funzione il più presto possibile. Spesso siamo incoraggiati a pensare all’economia in questi termini, anche se non molto tempo fa ci è stato detto che la macchina funzionava da sola. Purtroppo non aveva un pulsante di pausa o di accensione/spegnimento, e se ne avesse avuto uno, sarebbe stato meglio non premere il pulsante di spegnimento, perché le conseguenze sarebbero state immediate e disastrose. Ma qui scopriamo, stupiti, che questo pulsante esiste. Tuttavia, potremmo essere tentati di pensare un po’ più oltre: cosa intendiamo esattamente quando parliamo di “economia”? In sostanza, se l’economia è il sistema con cui le persone vengono sostenute, nutrite e vestite, ospitate e persino intrattenute, allora, per la maggior parte di noi, l’economia ha fatto miracoli durante il confinamento. Ma se l’economia non è proprio l’offerta di beni di prima necessità, allora cos’è?
Qualsiasi persona sensata non sarebbe dispiaciuta se le tante attività che costituivano la nostra vita sociale riprendessero da dove si erano interrotte: dai pub alle piste da bowling, alle università. Ma il punto è questo: queste sono attività che, per la maggior parte di noi, appartengono alla “vita”, non all’”economia”. E va detto che le nostre politiche non hanno messo la vita all’ordine del giorno. Ma poiché dicono alle persone di rischiare la vita, la loro vita, per il bene dell’economia, è fondamentale capire cosa intendono con questa parola.
Sebbene sia ormai considerato un fatto naturale, l’idea stessa di un sistema chiamato “economia” è un concetto relativamente recente. Sarebbe stato incomprensibile per Lutero, Shakespeare o Voltaire. Gradualmente, la società ha accettato la sua esistenza, ma la realtà che copre è rimasta mutevole. Così, quando il termine “economia politica” entrò nell’uso comune all’inizio del XIX secolo, l’idea a cui si riferiva era molto vicina all’”ecologia” (suo cugino etimologico): entrambi i termini si applicavano a sistemi che erano considerati autoregolatori e che, fintantoché mantenevano il loro equilibrio naturale, producevano una ricchezza aggiuntiva – profitti, crescita, natura abbondante – di cui l’uomo poteva godere senza limiti.
Un eccesso di gloria
Ma sembra che siamo arrivati a una fase in cui l’economia non è un meccanismo per provvedere ai bisogni umani o addirittura ai desideri, ma soprattutto a quel piccolo surplus, la ciliegina sulla torta: quello che viene dall’aumento del PIL. Tuttavia, il contenimento ci ha mostrato abbastanza: non è altro che fumo ingannatore. In altre parole, siamo arrivati al punto in cui l’economia è solo un vasto nome in codice per un’economia di merda: produce eccesso, ma non un eccesso glorificato per il proprio superfluo, come avrebbe potuto fare l’aristocrazia in passato – un eccesso coltivato con violenza e presentato come il regno della necessità, dell’”utilità”, della “produttività”, insomma, di un freddo e frenetico realismo.
Quando ci viene chiesto di “far ripartire l’economia”, si fa riferimento proprio a questa stupida economia, dove i manager supervisionano altri manager: il mondo dei consulenti HR e del telemarketing, i brand manager, i senior dean e altri VP di sviluppo creativo (supportati dalla loro coorte di assistenti), il mondo degli amministratori scolastici e ospedalieri, coloro che sono pagati profumatamente per “disegnare” le immagini per le riviste dedicate alla “cultura” patinata di queste aziende, i cui operai, a corto di personale e surriscaldati, sono costretti ad occuparsi di pile di scartoffie superflue. Tutte queste persone il cui compito, insomma, è quello di convincervi che il loro lavoro non è una pura e semplice aberrazione. Nel mondo aziendale, molti dipendenti non hanno aspettato l’inizio del contenimento per convincersi di non contribuire alla società. Oggi, lavorando quasi tutti a casa, sono costretti ad affrontare la realtà: la parte necessaria del loro lavoro quotidiano viene fatta in un quarto d’ora; meglio ancora, i compiti che devono essere svolti sul posto – visto che esistono – vengono svolti in modo molto più efficiente in loro assenza. Un angolo del velo è stato strappato, e gli appelli a “rimettere in moto l’economia” dominano il coro dei nostri politici, terrorizzati dal fatto che il velo possa essere strappato per sempre se ci vuole troppo tempo per ripendere.
Questo tema è di importanza cruciale per la classe politica in particolare, perché è fondamentalmente una questione di potere. Tutti questi battaglioni di lacchè, spacciatori di carta e pistoleri professionisti, penso che dovrebbero essere visti come la versione contemporanea del servo feudale. La loro esistenza è la logica conseguenza della finanziarizzazione, quel sistema in cui i profitti aziendali non derivano dalla produzione o addirittura dalla commercializzazione di qualsiasi bene, ma da un’alleanza sempre più stretta tra burocrazie imprenditoriali e governative, creata per produrre debito privato (…). Ecco un esempio concreto di questo sistema: recentemente un mio amico artista ha iniziato a realizzare mascherine protettive in quantità industriali da offrire a chi lavora in prima linea. Ora riceve un comunicato stampa in cui si afferma che non le è permesso distribuire mascherine, anche gratuitamente, senza aver prima ottenuto una licenza molto costosa. Si tratta di una richiesta che nessuno potrebbe soddisfare senza un prestito; pertanto, all’individuo non viene solo chiesto di commercializzare la sua attività, ma anche di fornire all’apparato finanziario la sua quota di tutti i ricavi futuri. Qualsiasi sistema che operi secondo il principio della semplice estrazione di fondi dovrebbe quindi ridistribuire almeno una parte della torta per conquistare la fedeltà di una certa quota della popolazione – in questo caso, le classi dirigenti. Da qui le stronzate del lavoro.
Come ha rivelato la crisi del 2008, i mercati finanziari globali sono solo strumenti per speculare sulle prossime strategie per ottenere una rendita – un sistema basato sulla potenza militare statunitense. Nel 2003, Immanuel Wallerstein ha persino suggerito che l’intero consenso di Washington degli anni Novanta si basava su questa realtà: in preda al panico per il declino del dominio industriale statunitense e gli inesorabili progressi dell’Europa, dell’Asia orientale e dei Brics [paesi emergenti]: Brasile, Russia, India, India, Cina, Sudafrica, ndr], l’impero americano cercava disperatamente di ostacolare il progresso dei suoi concorrenti insistendo sulla “riforma del mercato”, una riforma il cui principale effetto sarebbe stato quello di costringerli ad adottare lo stesso modello di business, questa burocrazia inetta e dispendiosa che era prevalente negli Stati Uniti. Sono le persone che un Donald Trump o un Boris Johnson vuole rimettere al lavoro a tutti i costi: quelli che fanno non le mascherine, ma le licenze per operare.
La “famosa” produttività
È ovvio che staremmo meglio se molti dei posti di lavoro messi in attesa venissero presto ripristinati; ma ci sono forse ancora più posti di lavoro che sarebbe nel nostro interesse non vederne il ritorno – soprattutto se vogliamo evitare una catastrofe climatica assoluta. (Basti pensare alla massa di CO2 vomitata nell’atmosfera e al numero di specie animali sradicate per sempre, al solo scopo di alimentare la vanità di quei burocrati che, piuttosto che lasciare che i loro lacche’ lavorino da casa, preferiscono tenerli a portata di mano in cima alle loro scintillanti torri).
Se tutto questo non ci sembra un grido di verità, se non ci interroghiamo più di tanto sui meriti del rilancio dell’economia, è perché siamo abituati a pensare all’economia secondo il metro di quella vecchia categoria novecentesca, la famosa “produttività”. Sappiamo che molte fabbriche hanno chiuso, forse tutte. Sappiamo anche che le scorte di frigoriferi, giacche di pelle, cartucce per stampanti e altri prodotti per la pulizia non si ricaricano da soli. Ma se la crisi attuale ci ha permesso di trarre una conclusione, è che solo una piccolissima parte dell’occupazione, anche la più indispensabile, è veramente “produttiva” in senso classico, cioè produce un oggetto fisico che prima non esisteva. E la maggior parte dei lavori “essenziali” sono infatti un’estensione della catena di cura: occuparsi di qualcuno, curare un malato, insegnare agli studenti, spostare, riparare, pulire e proteggere gli oggetti, provvedere ai bisogni di altri esseri o assicurare le condizioni in cui possono prosperare. Di conseguenza, la gente comincia a capire che il nostro sistema di compensazione è altamente perverso, perché più si lavora per prendersi cura degli altri o per arricchirli in qualche modo, meno probabilità ci sono di essere pagati.
Ciò che è meno percepito è la misura in cui il culto della produttività, la cui principale ragion d’essere è quella di giustificare questo sistema, ha raggiunto un punto in cui si sta ingolfando. Tutto deve essere produttivo: negli Stati Uniti, il Federal Reserve Bureau of Statistics arriva a misurare la “produttività” del settore immobiliare! Dove è chiaro che il termine è un eufemismo per “profitti”. Ma i dati della Fed mostrano anche che la produttività nei settori dell’istruzione e della sanità è a mezz’asta. Basta una piccola ricerca per capire che i settori della sanità sono proprio quelli più travolti dai quantità oceaniche di scartoffie con l’obiettivo finale di tradurre i risultati qualitativi in dati quantitativi, che possono poi essere integrati in fogli di calcolo Excel per dimostrare che questo lavoro ha un qualche valore produttivo – ovviamente ostacolando l’insegnamento, il coaching o la cura reali. Poiché i “contatori” e gli esperti di efficienza sono stati i primi a lasciare gli ospedali e le cliniche all’inizio della pandemia, molti lavoratori in prima linea e altrettanti pazienti hanno potuto constatare di persona che la macchina funziona molto meglio senza questi dirigenti.
È quindi comprensibile che gli appelli a stimolare l’economia siano solo incentivi a rischiare la vita per riportare i contabili nei loro cubicoli. Questa è pura follia. Se l’economia può avere un significato reale e tangibile, deve essere questo: il mezzo con cui gli esseri umani possono prendersi cura l’uno dell’altro, e rimanere in vita, in ogni senso della parola. Cosa richiederebbe questa nuova definizione di economia? Di quali indicatori avrebbe bisogno? O tutti gli indicatori dovrebbero essere abbandonati per sempre? Se ciò risultasse impossibile, se il concetto è già troppo saturo di false supposizioni, faremmo bene a ricordare che fino all’altro ieri l’economia non esisteva. Forse quest’idea ha fatto il suo tempo.
Articolo pubblicato su Libération, il 27 maggio 2020
(trad. dal francese di A. Fumagalli)
